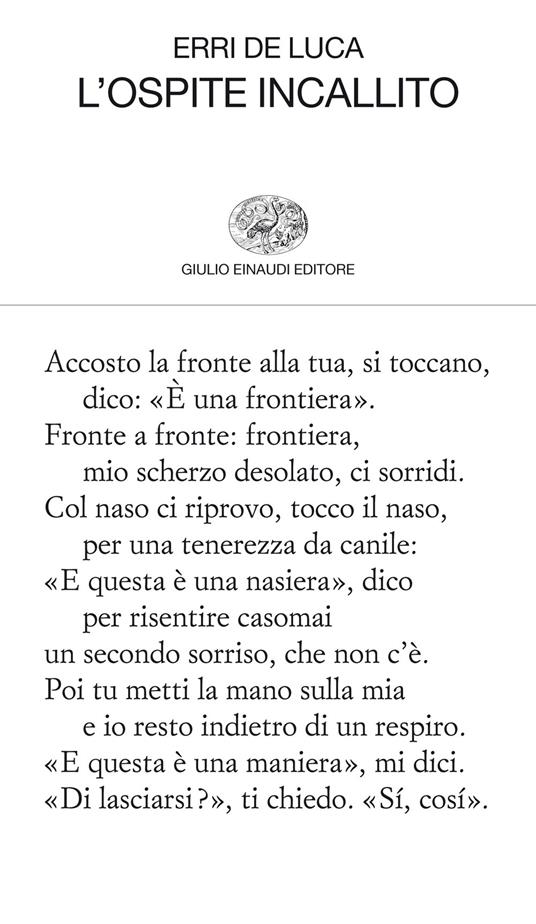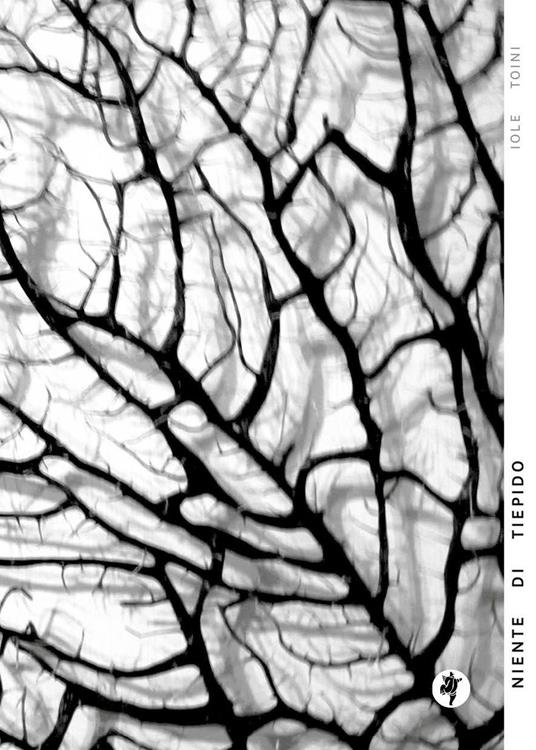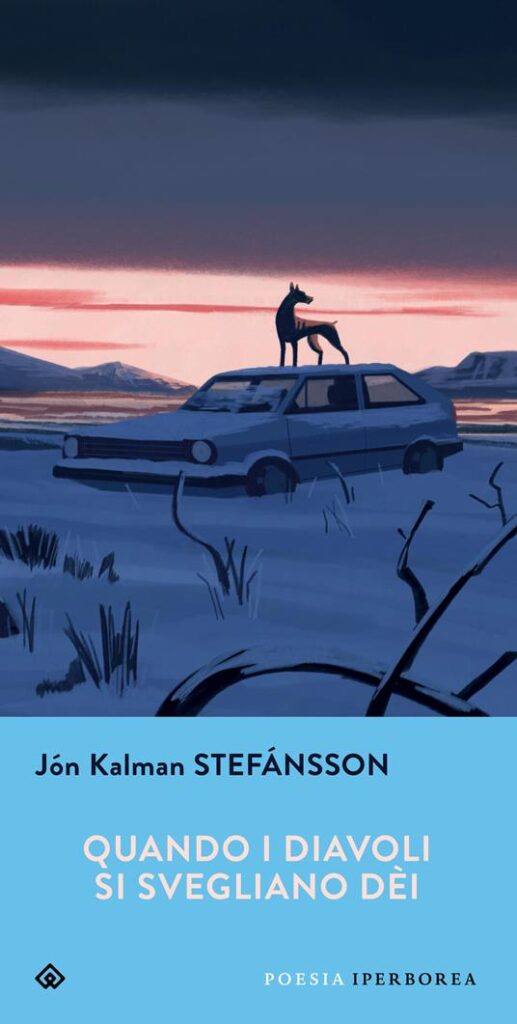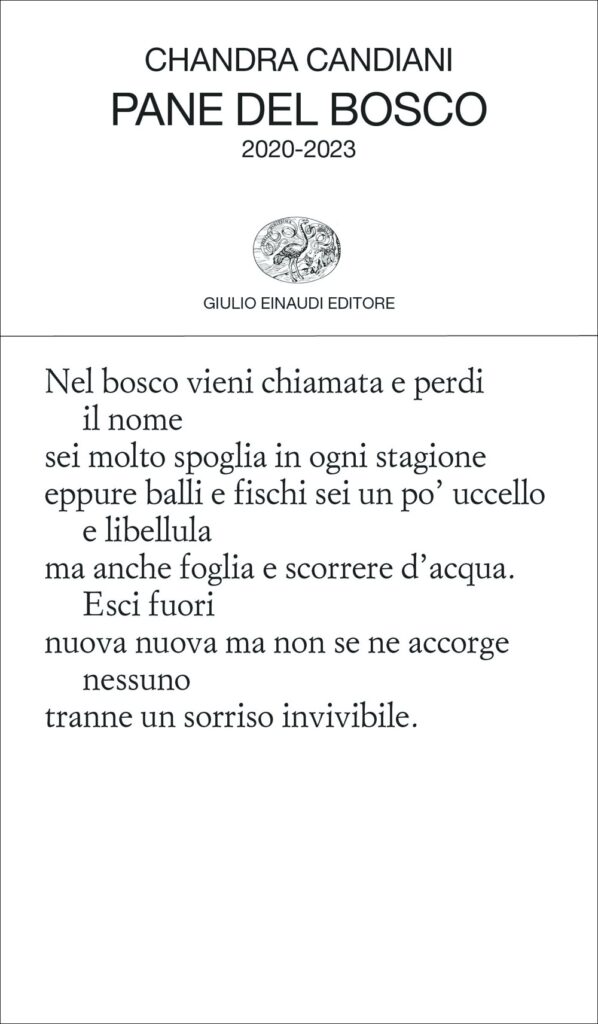Il soffio di Dio, il sorriso del poeta: Il cielo pende dai lampioni di Enzo Cannizzo
Enzo Cannizzo è un poeta che dà del tu a Dio. Anzi, la familiarità con il creatore è tale che il poeta può permettersi la minuscola («dio») con cui si cerca, con movenze ironiche e sornioni, un vecchio amico. Volendo, si potrebbe anche parlare di un “affiatamento” cameratesco tra i due, nel nome del fiato/ruah della creazione nei confronti del quale il Cannizzo de Il cielo pende dai lampioni (Algra, 2020) sembra nutrire un’ossessione che non vorrebbe essere solo poetica; non si contano, a questo proposito, le tante occorrenze di soffio («un soffio precede la parola», p. 27; «il soffio è frana sopita», p. 58; «il soffio è argilla / frana setaccio crepa», p. 67), e ancora di fiato e di respiro, nella raccolta in questione. Qui il poeta non fa a gara con la divinità – l’esito sarebbe certamente scontato e sproporzionato – ma semmai cerca di cavarla fuori dalla solitudine impenetrabile in cui da sempre è stata relegata dall’umano. Così il Dio terribile del Testamento ebraico cede il posto a un «vecchio dio lo zoppo / pagliaccio esodato dal circo» (p. 16), ovvero «un dio vagamente vanesio» (p. 32), non certo per una deminutio blasfema dell’attributo divino, quanto per l’urgenza – religiosissima – di una “somiglianza” ancora più prossima all’umano. E cosa c’è di più specifico del riso per mezzo del quale la nostra specie, a quanto ci dicono, si distingue da tutte le altre? Il riso di cui parliamo, naturalmente, sa essere anche amaro, come ci insegna quel Qohèlet «figlio di Davide» che vede la ruah declinarsi in havèl, spreco, fumo, sostanza dello «schianto dolcissimo / di un altro mattino» (p. 14). E forse Il cielo pende dai lampioni vuole essere, prima di tutto, una forma di preghiera che dietro la maschera del cinismo clownesco avvalora la nostra dipendenza creaturale dal logos («nei nomi / passiamo // nei nomi / restiamo», p. 82); una preghiera invero disperata («il tuo respiro / non ci tiene da tempo / per mano», p. 78) che punta dritto a quel sorriso di Dio/dio intravisto solo dai mistici e dai poeti disperati che vedono le parole incendiarsi nella loro bocca.
(Pietro Russo)
ENZO CANNIZZO, Il cielo pende dai lampioni, prefazione di Maria Attanasio, postfazione di Giovanni Miraglia, Viagrande (Catania), Algra editore, 2020, pp. 136, € 12 .